La storia di Benvegnuda Pincinella, strega di Nave bruciata sul rogo

Sinistra, mistica, femminista ed esoterica: è la storia di Benvegnuda Pincinella, la strega di Nave la cui vita è tragicamente piena di fascino. Vissuta nel Cinquecento, è stata – come vuole la nefasta e crudele tradizione – bruciata sul rogo con l’accusa di reati stregoneschi, scatenamento di tempeste, partecipazione ai sabba del Tonale… Fosse vissuta in secoli più moderni sarebbe stata una medica erborista, o semplicemente una donna indipendente. Ma era il XVI secolo, il secolo dei processi alle streghe e dei roghi, che non appartengono solo a Salem e Springfield (a tal riguardo, un bel saggio narrativo è «The ruin of all withces» di Malcolm Gaskill). Anche nel Nord Italia, e in questo caso a Brescia, i casi sono stati numerosi. Quello di Benvegnuda è tra i più noti e tramandati.
Chi era Benvegnuda Pincinella
Benvegnuda Pincinella visse nel Cinquecento a Nave, in un’epoca in cui magia, religione e superstizione facevano parte della quotidianità intrecciandosi con diverse implicazioni spirituali e politiche. La sua storia è ben raccontata anche dal giornalista e storico Maurizio Bernardelli Curuz nel libro «Streghe bresciane» del 1988, recentemente ripubblicato: le vicende della donna sono arrivate a noi, come spiega nel libro e come spiegava sul Giornale di Brescia nel 1983, grazie ai documenti processuali riportati dal cronista veneziano Marin Sanudo nei suoi «Diari», conservati alla Biblioteca Queriniana.
Benvegnuda era conosciuta come maga, strega e guaritrice: utilizzava rimedi naturali, parole magiche e invocazioni ai santi, ma anche strani oggetti (una cordicella che ricorda un pendolo, per esempio) per curare le persone. Moglie di Pinzino de Marsili, era piuttosto nota: a chiamarla per le sue doti erano tanto le donne comuni, quanto i personaggi notabili dei paesi vicini, come il conte Bernardino di Sodron.
La prima condanna
La prima condanna giunse nel 1509: la sentenza le impose di fare penitenza pubblica, ma anche il domicilio coatto e di indossare l’abito infamante davanti al duomo di Brescia. Nonostante ciò, Benvegnuda riprese quasi immediatamente la sua attività, curando tra gli altri la figlia del podestà Sebastiano Giustiniani e (a distanza) la madre di una certa Pasquina. Arrivò anche in Trentino, ospite dei Conti di Lodrone, e le cronache narrano della guarigione di un uomo ferito e di amuleti confezionati su richiesta. Come una mammana, racconta Bernardelli Curuz citando Sanudo, Benvegnuda insegnava anche a «far disperdere li puti, a far che una persona voglia bene a un’altra e a far che li mariti vogliano bene alle sue mojer et che non le possano batere si ben le mojer fanno le corna a li mariti suoi».
L’Inquisizione
Erano gli anni di intensa attività della Santa Inquisizione, che vigilava attentamente sui venti protestanti del Nord e sulle eresie che pare dilagassero nei paesi. A supporto dell’istituzione c’erano anche i semplici fedeli che, impauriti e smarriti dopo le epidemie di peste, spesso terrorizzati dal demonio, segnalavano all’autorità le situazioni poco limpide. Anche nel caso di Benvegnuda ebbero un ruolo primario: la comunità di Nave la sorvegliava per la sua fama di strega e così nel giugno del 1518 fu processata nel convento di san Domenico in città.
Il processo a Benvegnuda, che aveva all’epoca una sessantina d’anni, fu condotto da Lorenzo Mazi, che era vicario dell’inquisitore di Brescia Girolamo Da Lodi. L’accusa nei confronti della donna era quella di stregoneria. Si disse che tramite le sue cure la fattucchiera avesse provocato la morte di alcuni bambini e che, più in generale, la strega avesse partecipato ad alcuni riti eretici in Valcamonica e che avesse praticato incantesimi e magie.
Davanti agli inquisitori Benvegnuda Pincinella confessò diversi fatti, e su tutti di avere avuto rapporti con un demonio di nome Zulian, Giuliano. Confermò anche di aver partecipato ad alcune danze e ad alcuni riti nottetempo condotti da una fantomatica dea.

Nei verbali degli interrogatori non emerge solo la confessione, ma anche i costumi del tempo. «Come sono vestiti quelli che vanno al zuogo del Tonale?», le chiesero gli inquisitori. E lei rispose: «Alcuni con abiti di velluto, altri di damasco, altri ancora di panno e le donne con vesti di seta o di panno. È gente di ogni condizione e sorte: ci sono signori, gentiluomini cittadini e mercanti, artigiani e gente del popolo».
La morte sul rogo
Fu così che la donna venne condannata: la sentenza porta la data del 29 giugno 1518. Morì arsa viva in un rogo pubblico in piazza della Loggia nel luglio successivo. La pira di legna si trovava esattamente ai piedi dell’antica colonna con il leone di San Marco. Proprio come si legge nelle pagine del libro di Bernardelli Curuz: «Senza scope magiche e gatti diabolici, con il contatto di un ruvido saio sulla pelle, Benvegnuda Pincinella giunge in piazza Loggia a Brescia, fra un doppio cordone di birri. Zulian, suo diavolo custode, agile e fottutissimo rosso malpelo, l’ha definitivamente abbandonata. La pila di legna è stata preparata ai piedi della colonna, dove è appollaiato il leone di San Marco».
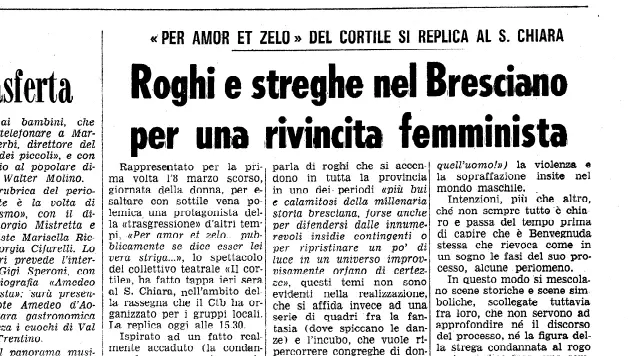
Nella cultura bresciana oggi Benvegnuda è una figura stimata e sentita. Negli anni la sua storia è stata narrata con diverse declinazioni, anche a teatro, e a Nave, suo paese natio, nel 2018 è stata affissa una targa per ricordarla: «In ricordo di Benvegnuda Pincinella – recita – medichessa erbaria, nel 500° anno in cui venne bruciata. Qui visse e portò sollievo». Firmato: L’Amministrazione comunale contro i pregiudizi, le discriminazioni, le ingiustizie.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.
