Cure Dolori di testa o di schiena, per ciascun male una terapia diversa
Ovidio Brignoli, medico di Medicina generale: «La regola fondamentale è fare una diagnosi corretta, perché ogni tipo di fastidio richiede farmaci diversi. Per farla, non servono esami particolari, necessari solo per sospetti importanti»
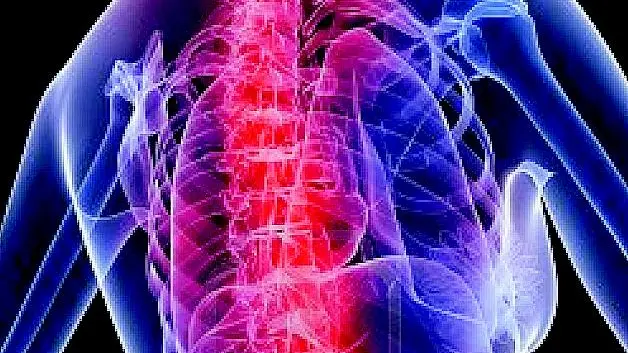
AA
nLa prima e più completa definizione del termine dolore è dell'International Association for the Study of Pain che, nel 1986, descrive il problema come «un'esperienza sensoriale ed emotivamente spiacevole associata ad un effettivo o potenziale danno tissutale o descritta come tale».
Il dolore, e la sofferenza che ne deriva, è una sensazione soggettiva alla quale ognuno risponde in maniera individuale. Qualunque sia la tipologia, acuto o cronico, qualunque sia la durata, l'intensità e la causa, è il risultato di un medesimo meccanismo fisiopatologico: partenza di uno stimolo doloroso dai recettori per il dolore; trasmissione del messaggio doloroso al midollo spinale fino al cervello; modulazione-elaborazione del messaggio; percezione del dolore. Il danno tissutale che è all'origine innesca una «cascata» di reazioni che portano alla produzione di sostanze infiammatorie, all'aumento dell'infiammazione e del dolore.
Esso è definito acuto quando dura non più di 12 settimane; diventa cronico quando si protrae oltre il normale decorso della malattia o del tempo previsto di guarigione (per più di sei mesi) e può continuare all'infinito.
Il dolore acuto più frequente è quello post-traumatico, post-chirurgico e quello che accompagna patologie acute (colica renale, cefalea, malattie osteoarticolari, frattura, appendicite, traumi di varia entità).
Una volta cronico, da sintomo diventa malattia. Oltre a incidere negativamente sulla patologia di base, può determinare modificazioni affettive e comportamentali, può condurre a invalidità o disabilità, determinando un deterioramento della qualità di vita e limitando le prestazioni lavorative.
Il dolore cronico può essere di due tipi, che possono combinarsi insieme: nocicettivo, cioè associato a un danno tissutale (ferite, fratture, scottature etc.) e neuropatico, che può essere causato da lesioni o disfunzioni dei sistemi preposti alla percezione o alla trasmissione della sensazione dolorosa, provocate da malattie che colpiscono il sistema nervoso centrale o periferico. Le cause più comuni del dolore muscolo-scheletrico sono i processi infiammatori articolari o periarticolari, le patologie articolari degenerative e le patologie muscolo-tendinee, oltre ai traumi e alle patologie ossee da frattura.
Di dolore abbiamo parlato con Ovidio Brignoli, medico di Medicina generale, vicepresidente della Società italiana di Medicina generale.
Il medico di famiglia è spesso il primo interlocutore dei pazienti in presenza di dolore acuto: quale percorso diagnostico viene seguito per capirne natura e cause?
«La regola fondamentale è fare una diagnosi corretta. Si procede prima con un attento esame anamnestico che comprende la storia del paziente e la storia del suo dolore. Il medico lascia che il paziente racconti quello che sente, quindi inizia a porre una serie di domande: sede del dolore, durata, caratteristiche (se è un dolore che «batte», «stringe», che «brucia», «lancinante» e così via), modalità di comparsa (di notte, di giorno, col movimento), irradiazione, ossia dove si proietta il dolore, se il paziente ha assunto già farmaci o altro, e così via. Terminata questa sorta di intervista approfondita, si passa alla visita medica, sempre importante specialmente se il dolore è in sede addominale o toracica, che va fatta con un certo rigore partendo da un punto lontano dalla sede del dolore con una palpazione leggera poi più profonda fatta di manovre che possono anche evocare il sintomo doloroso. Anamnesi e visita definiscono il tipo di dolore: viscerale (quello di una peritonite), infiammatorio (estrazione dentale), centrale (lesione del sistema nervoso). Ogni tipologia prevede farmaci diversi. Gli antinfiammatori non steroidei, fans e coxib, sono elettivi per il dolore periferico, infiammatorio. Prima di prescrivere il farmaco, la dose e la durata del trattamento, si chiedono sempre diverse informazioni al paziente, specialmente quando la terapia è prolungata. Per arrivare ad una diagnosi corretta non c'è bisogno di ricorrere ad esami di laboratorio, radiografici o di «imaging»: un'ecografia o una Tac si chiedono solo in presenza di sospetti importanti».
Nell'esperienza del medico di famiglia che importanza ha la possibilità di diversificare e ampliare l'armamentario terapeutico per il dolore acuto e cronico?
«La possibilità di un armamentario farmacologico diversificato da utilizzare per i diversi tipi di dolore è fondamentale. Avere a disposizione un numero sempre maggiore di farmaci efficaci e ben tollerati è importantissimo, dal momento che su cento pazienti presenti in uno studio medico, il 50% chiede di essere visitato e curato per una sintomatologia dolorosa. Il dolore più frequente è il mal di schiena che, tuttavia, può avere origine da cause molto diverse tra loro. Negli ultimi anni sono stati compiuti passi avanti sia nella comprensione dei meccanismi patogenetici che sottendono al sintomo dolore, sia nell'acquisizione di molecole che permettono di agire sulla genesi stessa del dolore con efficacia e in sicurezza. In tal senso, tra i fans di recente introduzione si pone etoricoxib, molecola della quale si conosce molto bene il meccanismo d'azione marcatamente selettivo, da oggi autorizzato anche per il trattamento a breve termine del dolore moderato associato alla chirurgia dentale».
Il dolore, e la sofferenza che ne deriva, è una sensazione soggettiva alla quale ognuno risponde in maniera individuale. Qualunque sia la tipologia, acuto o cronico, qualunque sia la durata, l'intensità e la causa, è il risultato di un medesimo meccanismo fisiopatologico: partenza di uno stimolo doloroso dai recettori per il dolore; trasmissione del messaggio doloroso al midollo spinale fino al cervello; modulazione-elaborazione del messaggio; percezione del dolore. Il danno tissutale che è all'origine innesca una «cascata» di reazioni che portano alla produzione di sostanze infiammatorie, all'aumento dell'infiammazione e del dolore.
Esso è definito acuto quando dura non più di 12 settimane; diventa cronico quando si protrae oltre il normale decorso della malattia o del tempo previsto di guarigione (per più di sei mesi) e può continuare all'infinito.
Il dolore acuto più frequente è quello post-traumatico, post-chirurgico e quello che accompagna patologie acute (colica renale, cefalea, malattie osteoarticolari, frattura, appendicite, traumi di varia entità).
Una volta cronico, da sintomo diventa malattia. Oltre a incidere negativamente sulla patologia di base, può determinare modificazioni affettive e comportamentali, può condurre a invalidità o disabilità, determinando un deterioramento della qualità di vita e limitando le prestazioni lavorative.
Il dolore cronico può essere di due tipi, che possono combinarsi insieme: nocicettivo, cioè associato a un danno tissutale (ferite, fratture, scottature etc.) e neuropatico, che può essere causato da lesioni o disfunzioni dei sistemi preposti alla percezione o alla trasmissione della sensazione dolorosa, provocate da malattie che colpiscono il sistema nervoso centrale o periferico. Le cause più comuni del dolore muscolo-scheletrico sono i processi infiammatori articolari o periarticolari, le patologie articolari degenerative e le patologie muscolo-tendinee, oltre ai traumi e alle patologie ossee da frattura.
Di dolore abbiamo parlato con Ovidio Brignoli, medico di Medicina generale, vicepresidente della Società italiana di Medicina generale.
Il medico di famiglia è spesso il primo interlocutore dei pazienti in presenza di dolore acuto: quale percorso diagnostico viene seguito per capirne natura e cause?
«La regola fondamentale è fare una diagnosi corretta. Si procede prima con un attento esame anamnestico che comprende la storia del paziente e la storia del suo dolore. Il medico lascia che il paziente racconti quello che sente, quindi inizia a porre una serie di domande: sede del dolore, durata, caratteristiche (se è un dolore che «batte», «stringe», che «brucia», «lancinante» e così via), modalità di comparsa (di notte, di giorno, col movimento), irradiazione, ossia dove si proietta il dolore, se il paziente ha assunto già farmaci o altro, e così via. Terminata questa sorta di intervista approfondita, si passa alla visita medica, sempre importante specialmente se il dolore è in sede addominale o toracica, che va fatta con un certo rigore partendo da un punto lontano dalla sede del dolore con una palpazione leggera poi più profonda fatta di manovre che possono anche evocare il sintomo doloroso. Anamnesi e visita definiscono il tipo di dolore: viscerale (quello di una peritonite), infiammatorio (estrazione dentale), centrale (lesione del sistema nervoso). Ogni tipologia prevede farmaci diversi. Gli antinfiammatori non steroidei, fans e coxib, sono elettivi per il dolore periferico, infiammatorio. Prima di prescrivere il farmaco, la dose e la durata del trattamento, si chiedono sempre diverse informazioni al paziente, specialmente quando la terapia è prolungata. Per arrivare ad una diagnosi corretta non c'è bisogno di ricorrere ad esami di laboratorio, radiografici o di «imaging»: un'ecografia o una Tac si chiedono solo in presenza di sospetti importanti».
Nell'esperienza del medico di famiglia che importanza ha la possibilità di diversificare e ampliare l'armamentario terapeutico per il dolore acuto e cronico?
«La possibilità di un armamentario farmacologico diversificato da utilizzare per i diversi tipi di dolore è fondamentale. Avere a disposizione un numero sempre maggiore di farmaci efficaci e ben tollerati è importantissimo, dal momento che su cento pazienti presenti in uno studio medico, il 50% chiede di essere visitato e curato per una sintomatologia dolorosa. Il dolore più frequente è il mal di schiena che, tuttavia, può avere origine da cause molto diverse tra loro. Negli ultimi anni sono stati compiuti passi avanti sia nella comprensione dei meccanismi patogenetici che sottendono al sintomo dolore, sia nell'acquisizione di molecole che permettono di agire sulla genesi stessa del dolore con efficacia e in sicurezza. In tal senso, tra i fans di recente introduzione si pone etoricoxib, molecola della quale si conosce molto bene il meccanismo d'azione marcatamente selettivo, da oggi autorizzato anche per il trattamento a breve termine del dolore moderato associato alla chirurgia dentale».
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Condividi l'articolo
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
