«Conclave» e gli altri libri da leggere a maggio

La primavera del 2025 è un po’ una primavera papale. L’addio a papa Francesco e il benvenuto a papa Leone XIV hanno segnato il periodo e così l’occasione vien buona per approfondire il tema. Anche attraverso il lavoro di fiction «Conclave». Prima di guardare il film, non è una cattiva idea leggere il libro da cui è tratto. Anche se il premio Oscar vinto per la migliore sceneggiatura non originale, dice il redattore Francesco Alberti, è così meritato che, in questo caso, il cliché «era meglio il libro» forse non regge.
Gli altri giornalisti e giornaliste della redazione hanno invece spaziato: c’è chi si è dedicato a una sorta di romanzo che parla della storia recente della Romania, chi si è buttato sulla politica, chi sulla letteratura dominicana e chi sulla geografia. Ce n’è un po’ per tutti, dunque.
«Lettera al mio dittatore»
Di Eugène Meiltz
(Traduzione di Francesca Cosi e Alessandra Repossi, Bottega Errante Edizioni, pp.144, 17 euro)
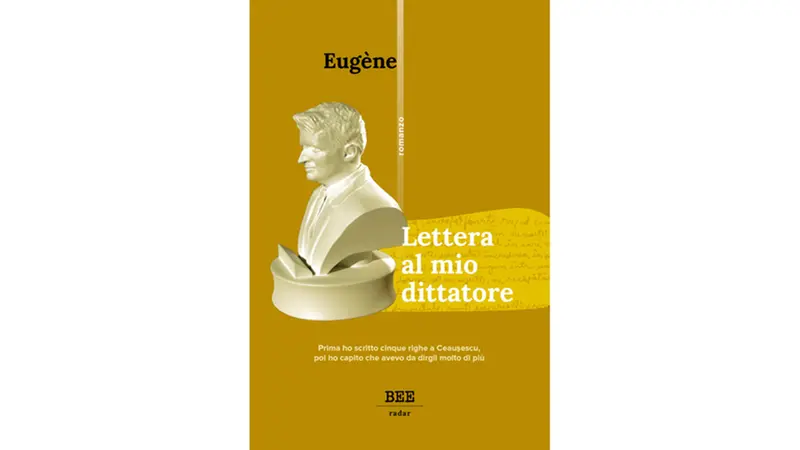
In attesa del ballottaggio alle elezioni in Romania il prossimo 18 maggio – che sancirà la collocazione politica del Paese, in bilico tra lo sguardo filorusso di Simion l’europeismo di Dan – un «romanzo» anomalo ne ripercorre la storia degli ultimi 50 anni, con il taglio personalissimo del diario, un tono tragicamente ironico, e la forma epistolare. L’autore, Eugène (Eugène Meiltz) dà del tu a Ceausescu in «Lettera al mio dittatore» mettendo il «conducator» al centro del proprio destino (i suoi genitori fuggirono in Svizzera dalla Romania nel 1974, lui li raggiunse un paio d’anni dopo, a soli sette anni d’età) e di quello di un Paese segnato dalla violenza del regime, ridotto al silenzio dalla Securitate e alla fame dall’economia dei piani quinquennali, manipolato dalla propaganda e soggiogato alla megalomania del tiranno.
Con leggerezza, nonostante i temi toccati, Eugène ci conduce alla scoperta di un Paese (lui lo fece da ragazzo, tornando in Romania in incognito prima della caduta del Muro, poi di nuovo da adulto) enigmatico nella sua chiusura al mondo, nei suoi buchi neri e nelle sue contraddizioni. E racconta la violenza di una società che imponeva alle donne di fare figli (l’aborto era un reato pagato duramente, lo stesso autore si considera un «decretuccio», figlio dei decreti che regolavano la maternità) per poi costringerle ad abbandonarli in orfanotrofi-lager, racconta la dittatura assoluta di Ceausescu tradotta plasticamente nella megalomania del gigantesco palazzo-reggia di dodici piani e 65mila metri quadri di area (ora è la sede del Parlamento e di molto altro) che si fece costruire mobilitando 700 architetti. Ma anche rievocando la manipolazione mediatica sulla reale portata delle rivolte a Timisoara che fecero cadere il regime, le fake sulle fosse comuni, il processo farsa al dittatore e alla moglie concluso con una fucilazione sommaria, la messa a tacere delle manifestazioni studentesche da parte del nuovo governo… La Romania è dietro l’angolo, i rumeni sono il gruppo di immigrati più numeroso nel Bresciano, il ballottaggio del 18 maggio può modificare gli equilibri in Europa: questa storia un po’ ci riguarda.
Giovanna Capretti, vicecaposervizio Cultura
«Conclave»
Di Robert Harris
(Traduzione di Annamaria Raffo, Mondadori, 2024, pp. 272 14 euro)
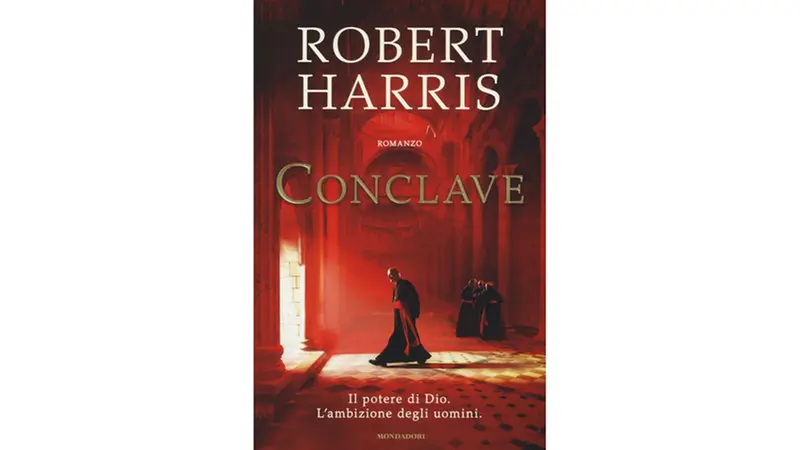
Il conclave (quello vero) ha eletto Leone XIV. Il conclave della fantasia (letteraria, ma soprattutto ormai cinematografica) ha eletto Innocenzo XIV. Il rito che sceglie il successore di Pietro non smette di affascinare. Dopo che il totopapa ha dominato le nostre conversazioni per giorni (specialmente sui social), ci siamo ritrovati a fissare il comignolo sopra la Sistina in attesa della fumata bianca. Abbiamo commentato anche i gabbiani attorno al camino, per dire com’eravamo messi.
In queste settimane che hanno sperato la morte di papa Francesco dall’elezione del suo successore si sono, però, sovrapposti due conclavi, o meglio tre. A quello reale ecco affiancarsi la trasposizione cinematografica del romanzo «Conclave» di Robert Harris. Una storia appassionante, con colpo di scena finale. Ma il film supera alla grande la pagina scritta, con buona pace di quelli che devono sempre ribadire «ma il libro è meglio», in una sorta di competizione intellettuale con il mondo. Eh no, stavolta è meglio la meravigliosa pellicola (chissà se si può ancora dire così) diretta da Edward Berger. I porporati che popolano il film hanno un impatto estetico talmente potente da causare la sindrome di Stendhal. Attenzione, quindi: si rischia la dipendenza. Ralph Fiennes è perfettamente strepitoso nella parte del cardinale decano. Cosa faccia il cardinale decano lo abbiamo imparato tutti in questi giorni. Se siete tra i pochissimi che non lo sanno leggete «Conclave» (questa è comunque una rubrica che consiglia libri). E poi guardate il film. Che è ampiamente meglio. E si può anche dirlo.
Francesco Alberti, redattore Cronaca
«Più uno - La politica dell’uguaglianza»
di Ernesto Maria Ruffini
(Feltrinelli, 2025, pp. 208, 18 euro)
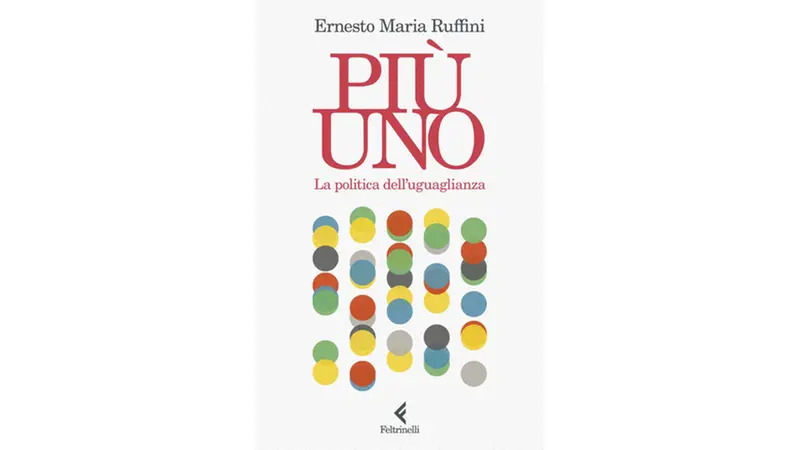
Ci sono il drago del debito pubblico e un sistema fiscale italiano «ingiusto». Ma nelle pagine di «Più uno» (Feltrinelli) di Ernesto Maria Ruffini emerge anche la certezza che le disuguaglianze si possono superare, in qualche modo sconfiggere, anche e anzi soprattutto grazie alla democrazia, per quanto «faticosa» questa possa essere, soprattutto se paragonata a più veloci, e illiberali, sistemi autoritari.
Una convinzione quella dell’avvocato ed ex direttore dell’Agenzia delle Entrate, dimessosi nel dicembre 2024 dopo forti dissapori col Governo Meloni, che si esplica attraverso pagine di lucida e a volte anche impietosa analisi del contesto socio-economico-politico, nazionale e internazionale. Non manca una forte critica alla politica, quella con la «p» minuscola, «smarrita e disorientata», che va di pari passo con la difesa e la valorizzazione di quella con la «p» maiuscola, la Politica che mette al centro il cittadino e non lo emargina ai bordi della vita pubblica.
E da Max Weber a Sabino Cassese, passando per John Maynard Keynes e Amartya Sen, Ruffini costruisce un discorso dove la speranza per un futuro più giusto non è svanita, sebbene sia da costruire in prima persona, un passo alla volta. Per creare, come recita il sottotitolo del libro, «la politica dell’uguaglianza».
Stefano Martinelli, redattore Web
«La breve favolosa vita di Oscar Wao»
Di Junot Diaz
(Traduzione di Silvia Pareschi, 2018, Mondadori, pp. 300, 13,50 euro)
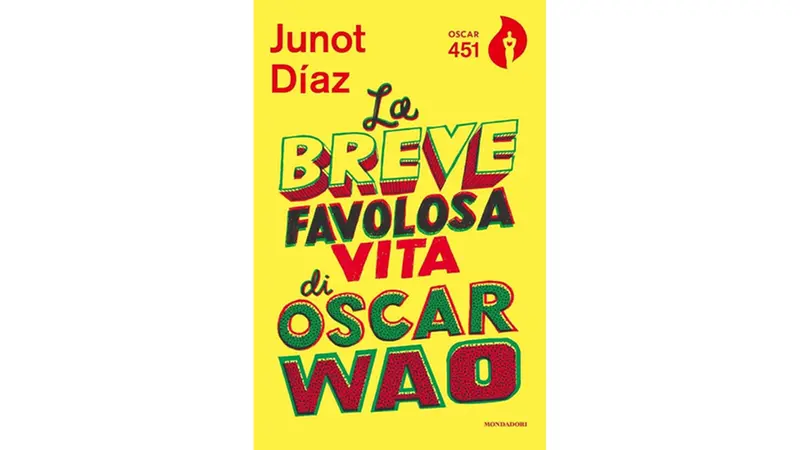
In quasi 39 anni di vita non mi era mai capitato di sentir parlare di letteratura dominicana e non mi era neanche mai passato per l’anticamera del cervello di esplorare la produzione letteraria dell’isola caraibica. Almeno questo è quello che pensavo prima di ritrovare una nota sul mio cellulare risalente al 2018: «Scrittore Junot Diaz, approfondire». Ricostruendo, a gettare il seme della curiosità era stato un articolo letto per caso sfogliando un vecchio New Yorker acquistato al Pageant Print Shop dell’East Village. Scrittore newyorkese, ma di origini dominicane, considerato già nel 1999 uno dei 20 migliori scrittori del mondo under40.
Ho recuperato le informazioni rimaste in sospeso dal 2018 e ho scelto di leggere «La breve e favolosa vita di Oscar Wao», libro con cui Diaz ha vinto il premio Pulitzer. Non so come sia la letteratura dominicana, ma me la ero immaginata esattamente così. Una lettura rapida, caotica e tagliente, fatta di tante sezioni con narratori diversi che provano a mantenere il filo di una storia: quella di Oscar de Leon e della sua maledizione di famiglia. Tanti termini figli dell’immigrazione verso gli Usa, altrettante escursioni nella terra dei miti e delle superstizioni caraibiche, tantissime citazioni nerd che sembrano uscite direttamente dal copione di «The Big bang theory», ma soprattutto la cruda realtà della dittatura di Rafael Leonidas Trujillo: questi gli ingredienti di un libro che mi ha dato la sensazione di trovarmi a una chiassosa tavolata in piena estate dominicana con il vicino di posto che prova a raccontarmi una storia. E tutti gli altri commensali, a modo loro, vogliono partecipare. Ognuno aggiunge qualcosa, ognuno vuole raccontarmi qualcosa e alla fine la storia di Oscar passa quasi in secondo piano, per lasciarmi tutto il resto.
Jacolo Bianchi, redattore Teletutto
«Storia d’amore e macchine da scrivere»
Di Giuseppe Lupo
(Marsilio, 2025, pp. 224, 17 euro, e-book 9,99 euro)
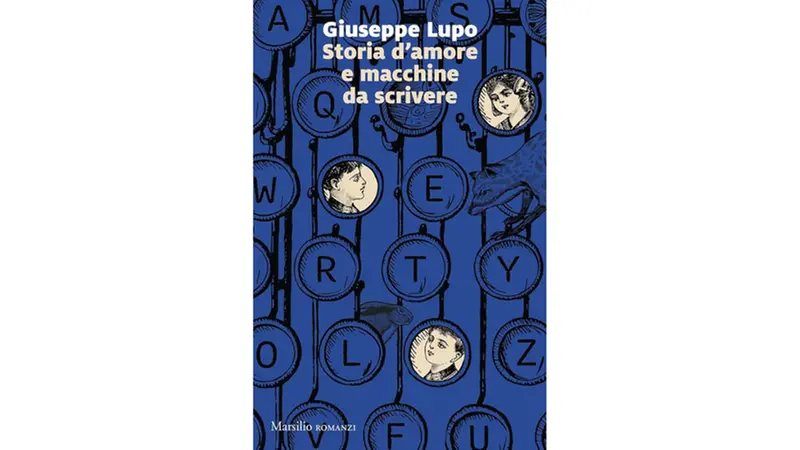
Salante Fossi, giornalista del Modern Times, è a Skagen, in Danimarca (il punto più a nord d’Europa), per intervistare nel giorno del suo novantacinquesimo compleanno il Vecchio Cibernatico, lo scienziato Sàndor Molnàr in odore di Nobel per una misteriosa invenzione chiamata Qwerty come le tastiere di macchine da scrivere e computer (dalle prime sei lettere da sinistra della fila di tasti superiore).
L’intervista si prospetta come una gara di nervi – l’anziano scienziato dice e non dice, cerca di continuo la moglie, sembra capriccioso –, ma Fossi non molla: per portare a casa il pezzo su Qwerty è disposto addirittura a seguirlo fino al luogo in cui vive, Cabo da Roca in Portogallo (il punto più a ovest d’Europa), e ascoltare la sua storia: un’affascinante storia personale che è anche la storia di un pezzo di Novecento e contiene una storia d’amore in cui gli amori in realtà sono due, quello per una donna e quello per le macchine da scrivere. Non a caso il Vecchio Cibernetico non si separa mai da una Olivetti Lettera 22.
«Storia d’amore e macchine da scrivere» di Giuseppe Lupo è un romanzo in movimento: tra confini estremi e attraverso confini (comincia a Budapest nel 1956, percorre mezza Europa con una tappa significativa in Italia, nell’Ivrea di Adriano Olivetti, e arriva negli Stati Uniti); tra passato, presente e futuro (con domande attualissime che richiamano senza citarla l’Intelligenza artificiale); tra romanticismo e tecnologia, corpi e macchine a cui pure Lupo riserva descrizioni appassionate, paragonandole di volta in volta a pianoforti, labirinti, mappe con sorprendenti terre di mezzo.
E se questi sono i temi principali di «Storia d’amore e macchine da scrivere», l’undicesimo romanzo di Lupo, che insegna Letteratura italiana contemporanea all’Università Cattolica, è autore di libri sul Novecento e collabora alle pagine culturali del Sole 24 Ore, offre altri spunti di riflessione: sulla memoria, la lingua, la scrittura, il giornalismo… E lo fa con tono lieve, a tratti trasognato, felice di raccontare.
Francesca Sandrini, vicecaposervizio Cronaca
«Luna comanche»
Di Larry McMurtry
(Traduzione di Gaspare Bona, 2025, Einaudi, 908 pagine, 24 euro)

La polvere, il dolore, la violenza, la carne e il sangue. E un pizzico d’amore. La pietà? Superflua. La speranza? Roba per pochi eletti. E, di certo, non in Texas. Con «Luna Comanche» si chiude – purtroppo – la meravigliosa tetralogia con cui Larry McMurtry ha narrato, a suo modo, la conquista del west. Un racconto dove l’epica si affianca ad una resa cruda, spietata di un mondo di frontiera che non fa sconti a nessuno.
Anche questa volta ritroviamo gli indomiti Ranges Gus McCrae e Woodrow Call. Appena promossi capitani, cavalcano senza sosta tra America e Messico sulle tracce di indiani, bandidos, capitani dell’esercito dispersi. Mentre all’orizzonte si odono i primi fischi delle pallottole della Guerra di Secessione. Niente è concesso alla retorica e se vi aspettate duelli in stile «Ok Corral», questo libro non fa per voi. «Luna Comanche» è un ritratto potente di una Nazione che nasce, gli Stati Uniti, ed una inesorabilmente destinata al declino, quella Indiana. Il tutto con una schiera di personaggi da urlo: Kicking Wolf e Buffalo Hump (spietati e sanguinari capi indiani), il crudele bandito Black Vaquero o il coraggioso capitano Inish Scull.
Leggetelo. Abbandonatevi al suo richiamo. E poi, se vi resta un po’ di forza, ricominciate da «Lonesome dove». È l’unico modo per accettare che le avventure di Gus e Call siano finite.
Rosario Rampulla, vicecaporedattore
«Le bugie delle mappe»
Di Paul Richardson
(Marsilio, 2025, pp. 240, 18 euro)
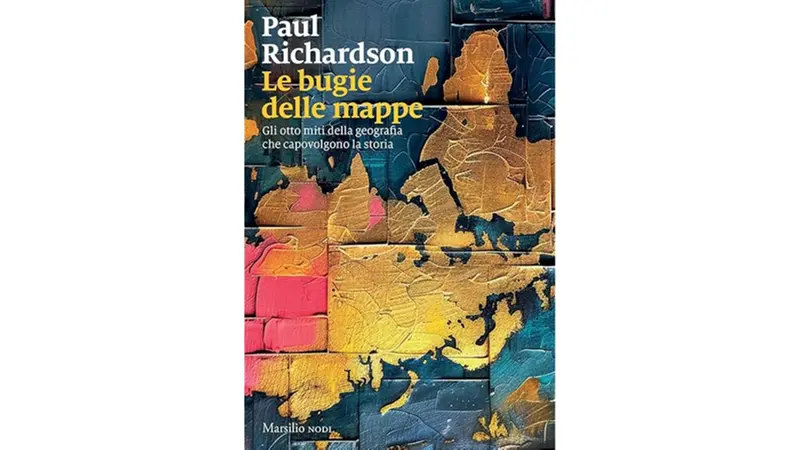
Alle scuole, da piccoli, viaggiavano in abbinata: storia e geografia. La prima, pur se non sappiamo trarne lezioni di vita, continua a incrociare i nostri passi e grazie al professor Barbero e ai suoi polloni conosce una popolarità ignorata prima. La seconda invece è meno alla moda, tanto che a parte qualche curiosità legata appunto ai tempi della scuola, giace placida e dimenticata, nel ripostiglio delle materie di second’ordine, un argomento da quiz televisivo, niente capo e tutta coda.
Per questo ci ha appassionato la lettura di «Le bugie delle mappe», anche se il titolo in inglese rende maggior giustizia: «Myths of Geography: Eight Ways We Get the World Wrong». «Miti della geografia: otto modi in cui fraintendiamo il mondo». E quali sono questi otto falsi miti, queste costruzioni mentali che secondo l’autore – Paul Richardson, professore di Geografia umana all’università di Birmingham – piegano la realtà e plasmano il nostro modo di pensare, condizionando scelte politiche e sociali?
L’elenco è presto fatto.
Il mito dei continenti: quanti sono davvero.
Il mito del confine: perché i muri non funzionano.
Il mito della nazione: che cos’è un Paese.
Il mito della sovranità: perché riprendere il controllo non è quello che sembra.
Il mito della misurazione della crescita: ricchezza, salute o felicità?
Il mito dell’espansionismo russo: come Putin ha scatenato il mostro revanscista.
Il mito della Nuova Via della Seta cinese: perché non tutte le strade portano in Cina.
Il mito dell’Africa destinata a fallire: andare oltre i cliché coloniali.
Ora, per chi ha la verità in tasca e cerca soltanto conferme alle proprie teorie, questo è un libro da evitare quanto la peste. Chi invece è curioso di conoscere e non teme di riconsiderare i propri preconcetti, le duecento pagine di «Le bugie delle mappe» correranno via veloci e permetteranno di guardare letteralmente al mondo con occhi nuovi.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Domenica
Rubriche, commenti, approfondimenti e idee da leggere con calma, quando e dove vuoi.
